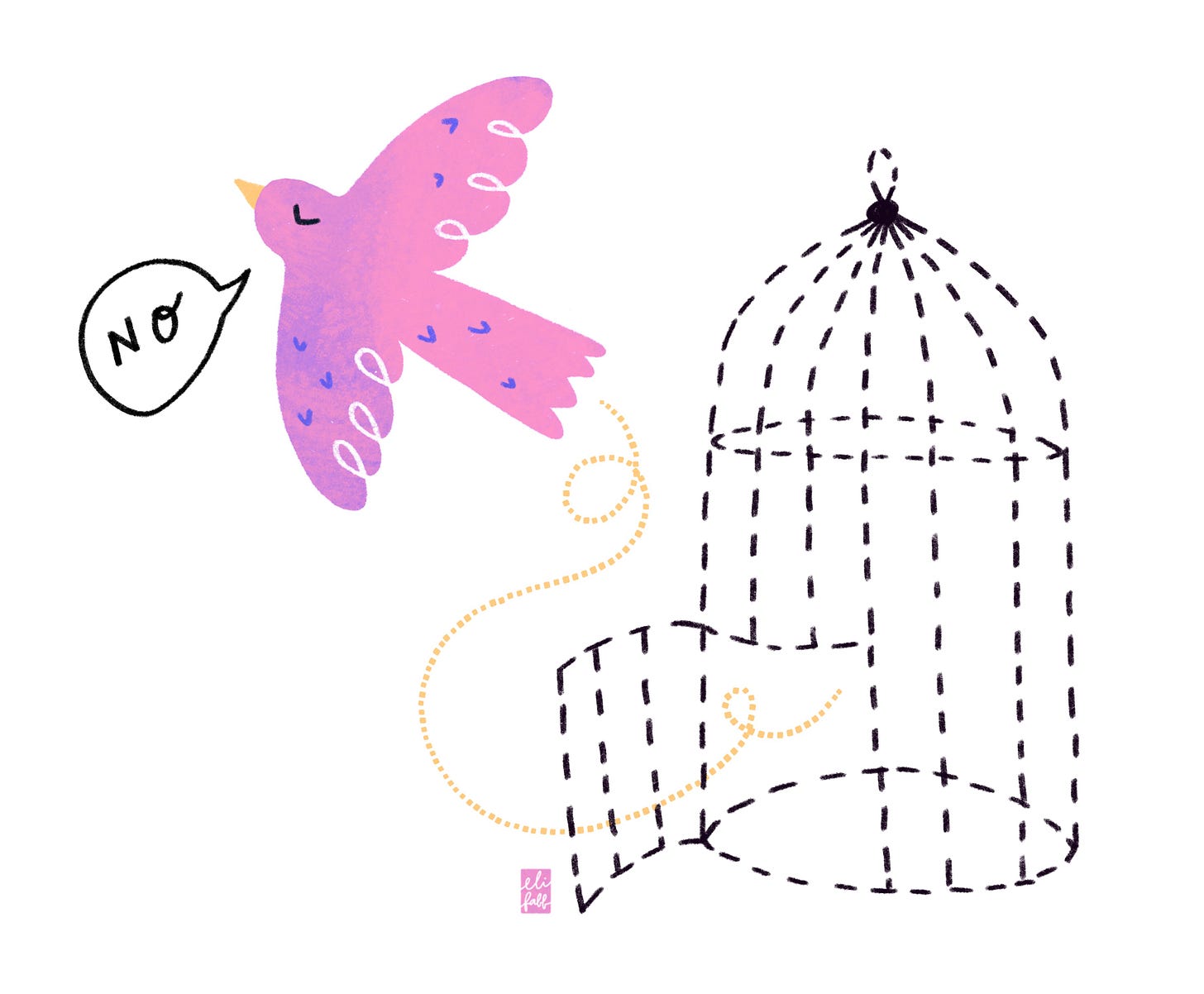#29 Dire di no
La logica del qualsiasi, o del mezzo che giustifica il fine
I find myself one day in the world, and I acknowledge one right for myself: the right to demand human behavior from the other. And one duty: the duty never to let my decisions renounce my freedom.
- Frantz Fanon, Black Skin, White Masks (1952)
Nello scorso numero di questa newsletter abbiamo chiacchierato sul valore di come si esercita il potere, al di là di chi lo detenga formalmente.
Un’implicazione di questa distinzione è l’importanza di saper ammettere quando si è in effetti la persona giusta, non per ciò che si rappresenta cosmeticamente ma per l’approccio che si ha verso il ruolo che si ricopre. In altre parole, significa sapersi tirare indietro quando il valore concreto del proprio ruolo declina, anche se quello simbolico resta forte.
Giusto un paio di settimane fa ne ha dato prova Jacinda Ardern, la prima ministra neozelandese, annunciando le proprie dimissioni: non perché coinvolta in uno scandalo, né per un calo del consenso, e neppure per cause di forza maggiore. Ma perché, semplicemente, ha esaurito le energie per ricoprire un ruolo di tale importanza.
Il discorso ha fatto scalpore, soprattutto dinanzi a un pubblico abituato a un certo poltronismo che spinge, ogniqualvolta si verifichi un evento simile, a cercare “ciò che sta dietro”, la “vera causa” delle dimissioni. Come se essere esauste non fosse una ragione vera, se solo una catastrofe potesse giustificare la rinuncia ad un incarico (specialmente se politico).
Ciò deriva, credo, da una certa percezione delle posizioni di leadership come un privilegio da tenersi stretto a qualsiasi costo, e più generalmente dall’idea che il lavoro sia una concessione da accettare a occhi chiusi, pena uno stigma di cui non ci si libera facilmente.
Rifiuti? Condannato/a. Capi d’accusa: ingratitudine, pigrizia, schizzinosità.
I nuovi comandamenti della nostra società:
Ama il tuo lavoro, anche se il tuo lavoro non ti ama.
Se proprio non lo ami, almeno ingoia il rospo e arriverai a fine mese.
Se non ci arrivi sii almeno grato/a, meglio questo che niente.
Si prendono per buoni questi comandamenti, dimenticando che il lavoro è in primis uno strumento. Non si tratta di cinismo: la classica frase “se ami il tuo lavoro non lavorerai un solo giorno in vita tua” è, consapevolmente o non, una romanticizzazione. Vi chiedo invece di allargare la prospettiva.
Numero uno: strumentale non significa strettamente finalizzato alla sussistenza. Quest’ultima, però, è certamente un fine che il lavoro deve contribuire a realizzare. Dunque, fine numero 1: sussistenza.
Numero due: un lavoro, se allineato alle inclinazioni di chi lavora, può contribuire alla soddisfazione di quella persona a livello personale, dunque essere strumento per il fine numero due: l’autorealizzazione.
Facciamo poi che questi due fini, sussistenza e autorealizzazione, siano presi come categorie più ampie per inglobare, rispettivamente, la sfera materiale e quella psicologica.
Il lavoro non è, in sé, né l’una né l’altra. Eppure, ciò che spesso accade è il formarsi di un circolo vizioso: il lavoro come mezzo non consente di raggiungere il fine, ma nessuno mette mai in discussione il mezzo, quindi si inizia a dubitare del fine stesso. Se il lavoro, lo strumento, diventa irrinunciabile, allora diventa esso stesso l’obiettivo da raggiungere, perché il prezzo da pagare – troppo amaro, troppo alto – sarebbe ammettere che quel mezzo non funziona.
Allora, l’elogio di un lavoro che monopolizza vite intere non significa forse adeguare gli obiettivi che ci si pone agli strumenti che si hanno per realizzarli e non viceversa, in un ironico scambio di priorità?
Dobbiamo abituarci, forse, all’idea che lo strumento va bene solo finché consente di raggiungere il fine. E che a sua volta il fine, essendo la priorità, va perseguito anche a costo di cambiare strumento.
Un tentativo di cambiare mezzo, seppur imperfetto, lo conosciamo tutti: proprio lui, quel reddito di cittadinanza che il nuovo governo ha deciso di ridimensionare.
I nuovi requisiti per accedere al reddito di cittadinanza colpiscono la categoria degli occupabili, ossia “persone di età compresa tra 18 e 59 anni, abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età”. Gli occupabili potranno ricevere il reddito soltanto per sette mesi e dovranno frequentare dei corsi di formazione o riqualificazione professionale per almeno sei.
Ma soprattutto, “il beneficio del reddito decade come nel caso in cui si rifiuti la prima offerta di lavoro.”
La prima che capita, a prescindere dal tipo di offerta, dalle condizioni di lavoro, dalla sostenibilità economica della posizione. Senza interrogarsi se quell’offerta sia uno strumento adeguato per la sussistenza e l’autorealizzazione, veri criteri di congruità – concetto inizialmente proposto e presto accantonato, ma che non faceva riferimento né all’una né all’altra.
Un lavoro qualsiasi non basta. Molti percettori del reddito facevano un lavoro qualsiasi, spesso in nero, sottopagato al punto da aver bisogno di integrare con un sussidio aggiuntivo. Molti di loro, facendo un lavoro qualsiasi, erano condannati all’invisibilità sociale: non disoccupati, ma senza le risorse necessarie per pagare l’affitto, le bollette, il cibo, le cure. Lavoratori poveri per definizione. Un lavoro qualsiasi non sempre assicura sussistenza, autorealizzazione, dignità. Non sempre è lo strumento adatto a raggiungere il fine.
Eppure la logica del “qualsiasi” – una donna qualsiasi, un lavoro qualsiasi – risponde alla retorica del “è già tanto se”: è già tanto se hai un lavoro; è già tanto se ci sei arrivata, a quella posizione. Una retorica fondata sul mantenimento dei privilegi esistenti da un lato e sulla stigmatizzazione della povertà dall’altra, perché se sei povero è colpa tua che non ti sei impegnato/a abbastanza.
Non del lavoro in nero, non di ammortizzatori sociali insufficienti e politiche attive del lavoro manchevoli, non di misure fiscali che favoriscono l’accumulo di ricchezza contro la redistribuzione – così che i poveri restino poveri e i ricchi diventino ancora più ricchi. Che ogni categoria si cristallizzi per quello che è, perché se le cose stanno così qualcuno se lo sarà meritato.
Quindi prendi l’elemosina e non creare problemi.
Ma se il lavoro diventa elemosina, allora rivendicarne la centralità non è più sostenibile. E non lo sarà finché non si abbandonerà l’idea che il mezzo giustifichi il fine, o in ultima analisi che le due cose coincidano.
Finché dire di no sarà percepito come una colpa e non come un diritto, finché si avrà la percezione di non avere scelta – anche se ciò a cui si sta dicendo di sì è costoso, inadeguato e frustrante –, allora la centralità del lavoro si traduce in un martirio.
Se non si ha scelta, o si sente di non averla, allora ogni diritto smette di essere tale e diventa qualcos’altro: favore, privilegio.
Se anche gli strumenti basilari per esercitare il proprio diritto all’esistenza divengono concessioni riservate a pochi, se tutto è sempre un po’ più inaccessibile e i criteri per accedere sempre un po’ più rigidi, cosa resta garantito se si rimane fuori?
In un sistema in cui tutte le possibilità appaiono ugualmente accessibili ma sono realmente alla portata di pochi, in cui tutti possono correre ma anche partire da dove vogliono, quali porte sono davvero aperte?
Se tutti possiamo pescare dallo stesso cesto ma le regole per essere ammessi alla pesca diventano sempre più stringenti, fino a che punto siamo liberi di scegliere? Fino a che punto ciò che scelgo è responsabilità mia e non l’effetto di dinamiche collettive su cui non ho capacità di azione?
E, soprattutto, questa morsa che continua a stringere nasce da condizioni oggettive? O è forse figlia di una certa narrativa che fa apparire come inevitabile, necessario, qualcosa di semplicemente possibile, contingente?
Liberarsi dall’aspettativa di un assenso incondizionato, accettare la legittimità del rifiuto, deve allora partire da una rottura delle catene mentali. E quindi riconoscere ciò che si può e non si può fare, in primis nella propria percezione. Bilanciare continuamente le possibilità, valutare se il mezzo è adeguato al fine.
E, finalmente, imparare a dire di no.
L’illustrazione di questa settimana è stata realizzata da Elisa, che ha interpretato questo testo come la possibilità di volare via: da una gabbia poi non così reale, i cui confini svaniscono man mano che si impara ad esercitare il diritto a dire di no.
I consigli di questa settimana:
Il libro da cui è tratta la citazione in apertura, dal titolo Pelle nera, maschere bianche. Un’analisi socio-politico-economica, ma anche un viaggio nell’anima di uomini e donne vittime di un colonialismo psicologico prima ancora che fisico. Liberarsi, per Fanon, significa proprio rompere le catene mentali e imparare che il mondo, e la propria vita al suo interno, può essere diverso da ciò che ci viene presentato come necessario e irrinunciabile.
Il profilo Instagram di Flavia Carlini, di cui trovate già due contenuti legati al reddito di cittadinanza come collegamenti nel testo. Davvero consigliato se vi interessa seguire l’attualità politica senza troppi giri di parole, con spiegazioni e commenti chiari, lineari, accessibili.
Due consigli già proposti in passato ma che riprendo perché particolarmente calzanti: Alessandro Sahebi, e in particolare questa importante riflessione sul lavoro povero; Il lavoro non ti ama, un podcast di Siamomine e Minimum Fax condotto da Priscilla De Pace ed Edoardo Vitale.
Come sempre, potete scriverci domande, dubbi e riflessioni all’indirizzo redazione@educationaround.org. Per continuare a seguire le nostre attività, ci trovate sui nostri canali social: